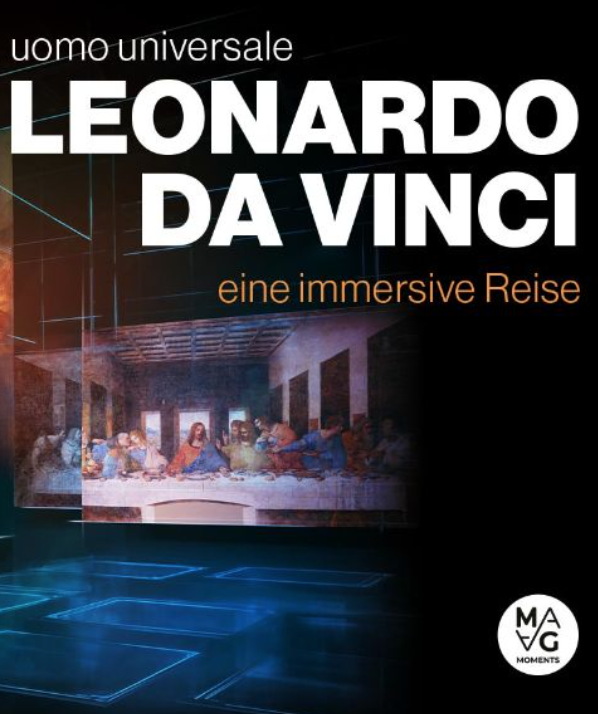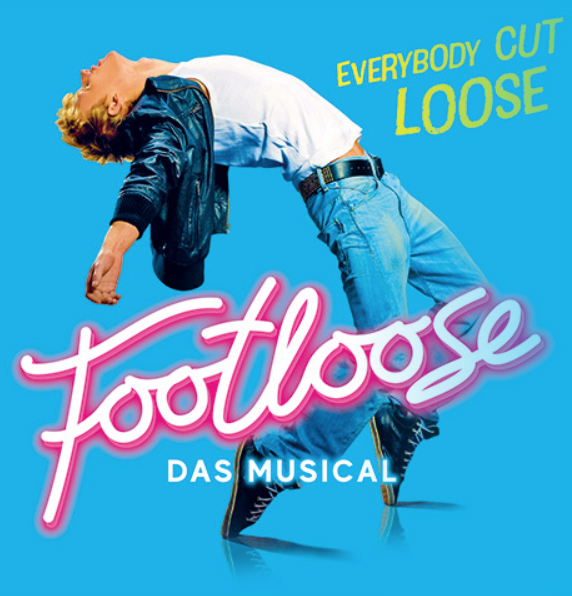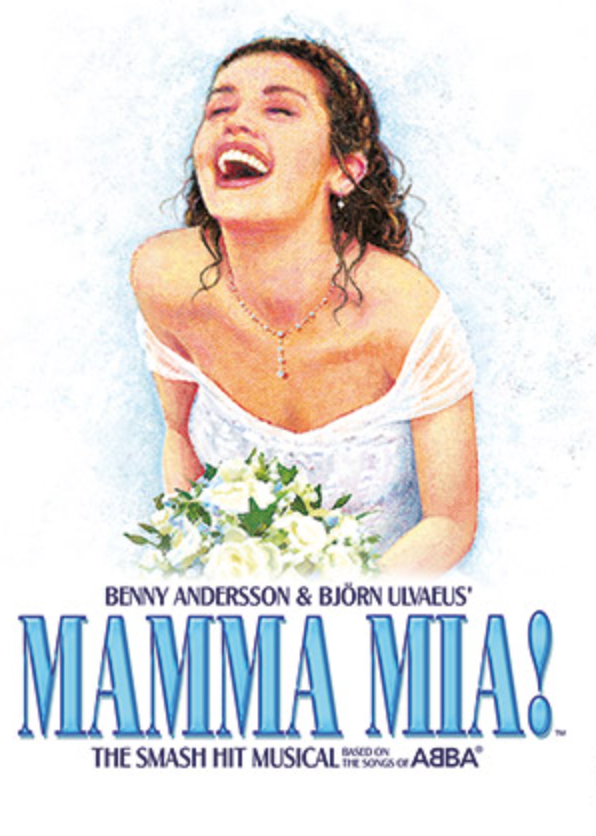- Details
- Redazione
I ricercatori del progetto International Pulsar Timing Array (IPTA), avvalendosi dei lavori e delle competenze di diverse collaborazioni di astrofisici di tutto il mondo - inclusi membri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e della Università di Milano Bicocca - hanno recentemente completato l’analisi del più completo archivio oggi disponibile di dati sui tempi di arrivo degli impulsi di 65 pulsar, ciò che resta di stelle di grande massa esplose come supernove. Questa accurata indagine sperimentale rafforza le indicazioni teoriche che suggerirebbero la presenza di un vero e proprio “brusio” cosmico, prodotto da onde gravitazionali di frequenze ultra basse (da miliardesimi a milionesimi di Hertz) emesse da una moltitudine di coppie di buchi neri super-massicci.
- Details
- Redazione
Un nuovo studio pubblicato dalla prestigiosa rivista Nature Communications spiega come il DNA si protegge dalle mutazioni causate dalla luce ultravioletta attraverso i suoi elementi costitutivi, i nucleosidi. I risultati, ottenuti sfruttando impulsi di luce di durata estremamente breve, potranno avere importanti applicazioni nelle nanotecnologie e in farmacologia, come la lotta al tumore della pelle. Lo studio è stato condotto da un team di ricercatori dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifn), del Politecnico di Milano, dell’Università di Bologna, dell’Università della Tuscia e dell’Heinrich Heine Universität Düsseldorf.
- Details
- Redazione
Con un investimento di 10 milioni di euro, SIMEST, società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, ha acquisito una partecipazione del 49% nella Granarolo USA, controllata americana della Società italiana leader nel settore lattiero-caseario. L’operazione è stata effettuata attraverso risorse proprie e con l’intervento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Details
- Redazione
E’ indubbio che le abitudini alimentari siano strettamente correlate alla salute e all’efficienza del sistema immunitario. Tuttavia, l’avanzare dell’età, così come gli scorretti stili di vita e uno stato di prolungato stress, come quello prodotto dalla Pandemia da Covid19, portano a compromettere la funzione immunitaria e carenze nutrizionali possono predisporre l’organismo ad essere più esposto ad infezioni. Il senso di stanchezza o spossatezza, caratterizzato da generale mancanza di energia e da affaticamento fisico e mentale, se non affrontato, può condurre ad una cronicizzazione della condizione.
- Details
- Redazione
Con il progressivo aumento dell’aspettativa di vita, aumenta anche la necessità di ricorrere alle protesi ortopediche per patologie dovute a invecchiamento, incidenti o disfunzionalità congenite. Il gruppo di ricerca di Elettromagnetismo Pervasivo di Ingegneria a Roma “Tor Vergata”, diretto dal professor Gaetano Marrocco, ha recentemente sviluppato una nuova tecnologia wireless applicabile a qualunque tipo di protesi che riesce a individuare e localizzare la presenza di micro-fratture, non rilevabili dall’esterno, prima che esse danneggino la protesi.
- Details
- Super User
IP sceglie Torino per sviluppare la ricerca e innovazione sulle nuove energie per la mobilità. Parte oggi, presso il parco tecnologico Environment Park, la cooperazione tra IP, la più grande azienda privata italiana del settore dei carburanti, di proprietà della famiglia Brachetti Peretti, e l’ecosistema della ricerca torinese.
- Details
- Redazione
Il 2021 si è concluso da poche settimane e gennaio è spesso il momento per tirare le somme di quanto accaduto nei precedenti 12 mesi. Complice anche l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, tra i vari ambiti della quotidianità degli italiani la sfera della salute e le problematiche legate al benessere hanno giocato un ruolo cruciale
- Details
- Redazione
Presso il Comando Operazioni Aerospaziali, si è tenuta una simbolica cerimonia di passaggio di consegne alla guida della componente aerea - Joint Force Air Component – della NATO Response Force tra il Comando JFAC italiano e quello francese, rappresentati dal Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini, Comandante del COA, e dal Generale B.A. Guillaume Thomas, Comandante della Brigade aérienne des opérations di Limonest.
L'Aeronautica Militare nel corso del 2021, per il tramite del Comando Operazioni Aerospaziali, ha guidato la Joint Force Air Component con il compito di pianificare, sviluppare, assegnare e condurre missioni aeree in conformità con le direttive del Joint Force Command (JFC).
- Details
- Redazione
L’Etna emette quantità di CO2 molto superiori a quelle di altri vulcani attivi e ciò si deve a serbatoi di carbonio profondi presenti sotto l’Italia meridionale, che liberano anidride carbonica a causa del movimento della placca ionica. È la scoperta di un team di geologi delle Università di Firenze e di Colonia e dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR, che ha utilizzato un sistema di analisi innovativo per ricostruire i processi alla base delle emissioni di CO2 di origine vulcanica. Lo documenta lo studio pubblicato sulla rivista Geology.